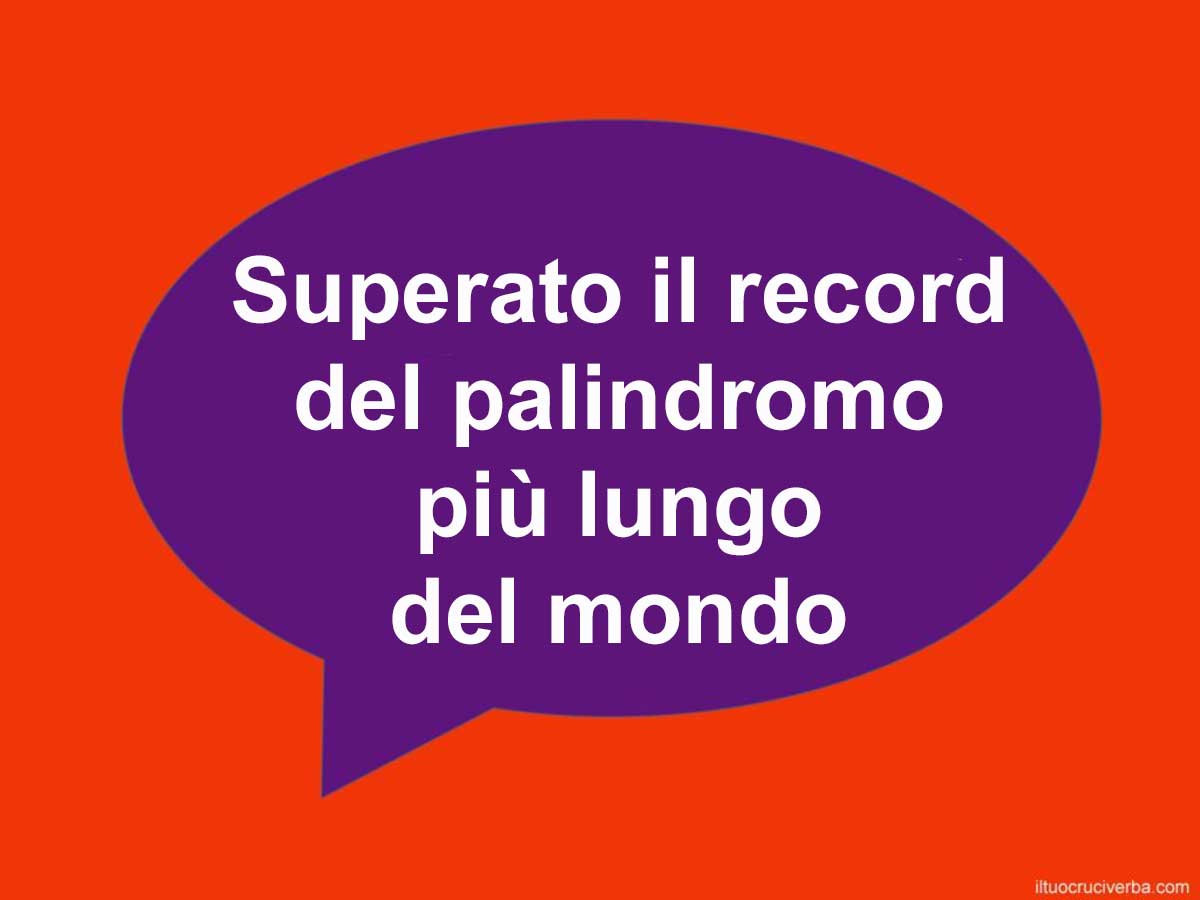Vi avevamo già dato conto del palindromo più lungo del mondo ma ora, ad aprile del 2025, c’è un nuovo record ed è di Alessandro Serra e che abbiamo intervistato. Alessandro Serra è nato a Vigevano nel 1998, ha studiato ragioneria e poi si è laureato in Economia, ma è sempre stato appassionato di giochi di parole e ama studiare le statistiche che riguardano il dizionario italiano.
Alessandro come è nata la tua passione per la ludolinguistica e i giochi di parole? C’è stato un episodio scatenante o è qualcosa che hai coltivato fin da piccolo?
Non c’è stato un episodio scatenante. Sono sempre stato appassionato di giochi di parole, come Ruzzle e Scrabble.
Hai parlato di una poesia palindroma di quasi 26.000 lettere: come ti è venuta l’idea di scrivere un’opera del genere? Qual è stato il punto di partenza?
Essendo appassionato di statistiche sulle parole ero già a conoscenza del “Vangelo Palindromo” di cui ho avuto modo di venire a conoscenza grazie a voi, ed ero anche al corrente di altri racconti palindromi in circolazione. L’ispirazione per la scrittura di quest’opera nasce proprio dal Vangelo Palindromo. Ammiro molto Gabriele de Simon e senza alcuna pretesa di eguagliarne la raffinatezza linguistica, la mia idea è stata quella di testare la scrittura palindromica su larga scala.
Come reagiscono le persone quando racconti della tua poesia palindroma? Hai già avuto modo di presentarla in pubblico o in contesti culturali?
Al momento nessuno lo sa.
La tua opera Divina Commedia Palindroma ha anche una struttura narrativa o simbolica, oppure è solo una sfida linguistica
Si tratta di un testo in versi interamente palindromo, che ripercorre tutti i canti della Divina Commedia, dal primo all’ultimo. A lato del testo viene indicato anche il canto corrispondente, in modo da dare un riferimento al lettore.
Sicuramente la sfida linguistica è preponderante rispetto al significato narrativo, ma ho cercato di mantenere un certo equilibrio tra simmetria e trama, mantenendo sempre il corretto ordine temporale degli eventi.
Ho dovuto necessariamente ricorrere a termini arcaici e desueti del dizionario italiano per poter mantenere la struttura del palindromo, l’opera potrebbe quindi talvolta apparire ostica o poco comprensibile. Il testo contiene esattamente 25.905 lettere.
Quanto tempo ti ha richiesto la stesura della Divina Commedia Palindroma?
Ci sono voluti circa 9 mesi. Un primo mese di “allenamento” in cui ho scritto frasi palindrome, ma senza un particolare significato, e successivamente 8 mesi di scrittura vera e propria, in cui ho cercato di conciliare il vincolo della scrittura palindroma al significato narrativo dell’opera.
Quali sono le difficoltà che hai incontrato?
Le difficoltà sono state soprattutto nelle fasi iniziali della scrittura. Non essendo abituato alla scrittura palindroma mi sembrava impossibile far coesistere significato e simmetria. Mi spaventava anche la quantità di lavoro e di tempo necessaria per completare un’opera simile. Dovendo raccontare ognuno dei 100 canti, alla scrittura vera e propria del palindromo è preceduta una fase di studio dell’opera, in modo da apprendere i concetti da
esprimere.
Hai utilizzato strumenti o software per aiutarti?
Non ho utilizzato nessun software, solo Word e il software online del dizionario italiano. Ho creato invece un software per verificare, al termine dell’opera, che il testo fosse effettivamente palindromo. L’intelligenza artificiale, invece, non mi ha aiutato proprio. Ad esempio, se si prova a chiedere a ChatGpt di comporre una frase palindroma a piacere, spesso non è minimamente in grado, fatta eccezione per le frasi già note come “i topi non avevano nipoti”.
Dove si può leggere o acquistare il tuo testo? Hai in mente altre pubblicazioni simili o progetti futuri?
Su Amazon e lo trovate cercando “Divina Commedia Palindroma”. Ho sicuramente in mente di realizzare altri progetti riguardanti lo studio delle parole.
Puoi condividere con noi qualche estratto?
Volentieri, ma ti premetto che per la stesura dell’opera ho suddiviso idealmente la Divina Commedia numerando i canti da 1 a 100. In questo modo, per esprimere un concetto contenuto nel canto numero 3, occorre utilizzare parole che, se lette inversamente, raccontino parti della Divina Commedia all’altezza del canto numero 98 (canto 31 del Paradiso). Pertanto ogni passo dell’opera esprime un concetto completamente diverso se letto al contrario.
Riporto di seguito alcuni passi dell’opera:
- Estratto n. 1: Inizio e fine dell’opera
in questo caso ho iniziato raccontando il primo canto dell’Inferno. In particolare Dante che
si ritrova smarrito, la paura, la vista del colle, l’incontro con le tre fiere, la presentazione di
Virgilio, la profezia del veltro e la spiegazione di Virgilio sul viaggio che Dante andrà a
compiere:
Ora c’è vero malanimo,
danna me, dolori.
Mirai putre via ria (lì rei).
Fiso colle beato,
v’è di là sede feroce:
è l’atro male, così vedo!
“E rapido lì salirò da l’erta!”
Poi lì fere, tre, lo so.
Sere poderoso, re, poeta è lo sommo!
“Su salire te devi!
Sì, veraci dolori, mali cane torrà!
Nocerà, la ira morde.
Viro, là vieni!
Grevi dolori, meta e Bice vedrai!” […]
Allo stesso tempo il testo, se letto inversamente, deve raccontare la fine della Divina Commedia, in particolare la lode alla Vergine di San Bernardo, Dante che supplica Maria di concedergli la vista, la visione della luce divina e dell’unità dell’Universo, la visione della trinità, il viso che appare umano, la vittoria dell’amore divino.
[…] veci beate!
“Miro, lodi Vergine!
I valori vedrò, Maria?” là reco, narro.
Tenaci là miro.
Lodi care, visive, d’eteri:
là su sommo Sole!
“A te operoso Re… d’opere!”
“So, solerte Re, Filio, Patre: l’adori!”
Là sì lodi!
“Pare (ode) viso: cela mortale?”
E core, fede salì devota.
È bello così! Fieri là i rai!
Vertù pia rimiro, lode.
Manna domina: l’amore v’è caro!
- Estratto n.2
Ci troviamo all’altezza del canto 26 dell’Inferno. Qui l’incontro con Ulisse e Diomede e il racconto del viaggio di Ulisse:
E là è Diomede, ma lì Ulisse!
Da idoli, l’atro mi disse novità:
Ercole visitò, vide fello,
vero girante della valle, navigatore!
Dolore folle tra marea,
là da barca, sì di vero male.
Re ne vide vette ree,
danna solenne!
[…]
Specularmente, ci troviamo intorno al canto 8 del Paradiso. Si narra dell’ascesa al cielo di Venere, il canto dell’Osanna, l’incontro con Carlo Martello, il racconto della sua vita in Sicilia e del suo regno, la spiegazione sulle diverse inclinazioni umane create da Dio, che non fa tutti gli uomini uguali:
[…]
Venne l’Osanna!
“Dee rette vedi”:
Venere! L’amore vidi, sacra bada!
Là era Martello, fero (lode) rota.
Giva nella valle d’Etna, rigore volle.
Fé, divoti, sì velo creativo.
Nessi di mortali, lodi:
“ad essi Lui, là, medemo ideale mai dà!”
[…]
- Estratto n.3 In questo caso ci troviamo tra il canto 17 e il canto 18 dell’Inferno. Si descrive il viso da uomo giusto di Gerione, gli usurai (cravattari) che guardano con orgoglio i loro indumenti e lo stemma di famiglia, la discesa in groppa a Gerione, il fuoco, le visioni di dolore e lamenti, l’arrivo nelle Bolge: […]
Valida cera, vera: pare omo, non è!
“Re solenne, vo!”
Notarono la tonaca cravattari: “sì, vi è!”
Atre bili ardevano, revelano ira.
A meta recò noi, lì sella.
Mar afoso: lai, giù crepiti…
Nifi sacri, dosso putre: vidi male!
“Ve’, retro si rota, nimico sì è!”
Rio pare, percosse dà.
E là bolge! È capa l’ira […]
Se leggiamo il testo al contrario ci troviamo tra il canto 16 e il canto 17 del Paradiso. In particolare si narra di Cacciaguida che descrive il popolo fiorentino, Dante che chiede al trisavolo la sua sorte futura, la profezia ull’esilio di Dante e sul suo rifugio a Verona, il novenne Cangrande della Scala (detto Can), la necessità di Dante di sapere la verità:
[…]
La pace è globale adesso, creperà poi!
Rei, soci minatori!”
“Sorte revelami!”
“Di vertù, posso dir casi finiti,
per cui già lo so:
farà mal l’esilio, nocerà te!
Ma a rionale Verona vedrai libertà,
è ivi sì ratta!
Varca Can, o tal onorato novenne!”
Lo sere non omo era, pareva.
“Reca, di’ la verità!” […]
- Estratto n.4: il centro dell’opera. Il centro dell’opera palindroma si trova tra il canto 16 e il canto 17 del Purgatorio. Si esprimono qui vari concetti, tra cui la spiegazione di Marco Lombardo sul libero arbitrio dell’uomo, la corruzione umana, i tre vecchi, simbolo di antica virtù. Successivamente la continuazione del viaggio di Dante e Virgilio, l’apparizione dell’angelo della mansuetudine, la spiegazione di Virgilio sull’amore che talvolta può errare, se diretto all’oggetto sbagliato. […]
Vidi l’omo, e c’è lì vero male!
Là eroi, parola tonò:
“diro c’è… mortale desiderio!
Pena, ira, malo dolore mosse!”
Mere purezze: tre cari divi, seni.
Videro là virtù nette,
valori meri, sommi.
Là su salimmo.
“Sire! Miro là vette!”
“Nutri valore, divin è,
sì vi dirà certezze”.
“Rupe, re!”
Messo mero lodò là mariane,
poi re di sede latrò me cori:
“dono talora pio, reale, l’amor è vile!”
[…]
Infine, c’è un consiglio che daresti a chi vuole avvicinarsi alla scrittura palindroma?
Partire provando a scrivere una frase palindroma qualsiasi, senza particolare significato. Successivamente identificare una parola chiave per esprimere un certo concetto e costruire “intorno” ad essa una frase di senso compiuto. Occorre anche identificare le parole adatte per essere utilizzate in frasi palindrome. Ad esempio “discorso”, per la sua composizione letterale, non è utilizzabile. Invece, meglio utilizzare termini come “parola”, voce”, “citare” che, se letti al contrario, sono abbinabili a parole di senso compiuto. Si può iniziare quindi a
comporre piccole frasi, come:
“ieratico, tal alato cita rei”
“è nome da demone”
“e ritrama dono da martire”
Ci vuole un po’ di allenamento.

Giornalista e marketer, sono esperto di giochi di parole, rebus, enigmistica e cruciverba. Ho lavorato nel tour operating e poi nel digital, presso i più importanti publisher online, come responsabile del desk editoriale. Nutro sempre una passione sconfinata per i viaggi e per le parole. La esprimo con i contenuti pubblicati su questo sito, con cui spero di offrire momenti di svago intelligente agli utenti.